“Il Piemonte è sempre stata una regione di consumo più che di produzione ne’ riguardi del cavallo”, diceva il Moreschi nel suo libro “Industria stalloniera” del 1903: ma oggi, più di cento anni dopo, i piemontesi si sono migliorati e in provincia di Cuneo abbiamo il maggior numero di allevatori italiani del Cavallo di Mérens. Il piccolo grande morello dei Pirenei qui ha trovato una seconda patria, lontana dalle valli dell’Ariége ma fatta delle stesse montagne e abitata dalla stessa gente. Per conoscerli meglio abbiamo approfittato della III Mostra Nazionale del Cavallo di Mérens che si è tenuta a Demonte, in Valle Stura, dal 21 al 23 settembre 2007. Ma i nostri bei montanari non erano mica lì ad aspettarci a valle, impigriti dentro un box: lasciata la macchina in paese siamo stati prelevati al volo da Fortunato Bonelli, uno degli allevatori storici di questa razza, e siamo andati ad incontrare i protagonisti della Fiera che stavano arrivando dalla Val Varaita e dalla Val Maira con una transumanza in piena regola. La strada è incastrata tra i denti di queste montagne che lasciano poco spazio alla valle e si arrampicano subito altissime tutte intorno, si corre su una strada a metà tra il cielo limpido sopra di noi e il torrente che sembra un filo sottile di luce giù in fondo, ma come facevano Pantani e Savoldelli a scendere da qui a rotta di collo per contendersi una tappa del Giro d’Italia? Noi invece saliamo, chiacchierando con Fortunato che è stato allenatore della nazionale di Sci di fondo, sci-alpinista per passione e allevatore di mestiere ma adesso parla solo come una persona nata qui, che ama e conosce profondamente ogni cosa di cui sono fatte le sue montagne: “Ho preso il mio primo cavallo di Mérens nel 1980, perché le capre mi scartavano tanto fieno: loro mangiano solo la parte migliore, mentre il cavallo mangia tutto quello che rimane. Poi ho aumentato il numero di capi, lasciato perdere le capre e trasferito i cavalli su in alto, al pascolo: i Mérens sono ottimi pascolatori, molto rustici. I puledri il primo anno pascolano male perché non hanno esperienza, mentre a due sono spesso troppo grassi, sanno mangiare ma non hanno ancora la voglia di giocare tra di loro che li caratterizza a tre, quando gli ormoni cominciano a farsi sentire. Ogni giorno controllo i cavalli su al pascolo, li guardo col binocolo e si vede subito se stanno bene: se hanno la testa giù vuol dire che hanno da mangiare, anche d’inverno con la neve loro scavano con lo zoccolo e trovano quello che serve. Quando non ci riescono la femmina più vecchia si mette in cammino e scende tutta la mandria fino a casa, solo una volta sono dovuto andarli a prendere perché le slavine avevano bloccato il sentiero ed erano tornati indietro: ho aperto un passaggio nella neve con la pala, e il giorno dopo erano tutti a casa. Passeranno in stalla tre o quattro giorni l’anno”. Arriviamo all’altopiano della Bandita, dove cavalli e cavalieri si stanno riposando prima dell’ultima, lunga tappa: i prati gialli per la siccità estiva sono profumati di erbe saporite, i cavalli stanno pascolando tranquilli divisi in due gruppi. Sono tutti morelli decisi tranne uno, un puledro bello e vispo ma sauro in modo imbarazzante: ogni centinaio di nuovi nati ne salta fuori uno, ultima testimonianza di quel bretone che nel dopoguerra aveva coperto alcune fattrici Mérens per fare puledri da carne. Ma il piccolo alézan dalla bella lista bianca non sa di essere diverso e fa il bravo Mérens come tutti gli altri, attaccato al fianco della mamma giù per questa strada militare costruita durante il regime fascista per il Vallo Alpino (dopo l’alleanza coi tedeschi i francesi divennero i nemici da cui proteggersi, qui siamo a due passi dal confine) e che segue il tracciato della vecchia mulattiera settecentesca, le cui pietre lucide sbucano ancora in certi tratti tra i ciuffi d’erba. Alcuni cavalieri rimontano in sella, altri una volta tirate su le staffe e tolto il filetto lasciano andare avanti il loro cavallo con le fattrici e i puledri, tutti insieme seguono la cavalla che fa da capobranco ed è condotta sottomano da Michelangelo, barba ispida e sorriso a metà strada tra timido e splendente. I campani delle fattrici sembrano fatti d’argento tanto suonano chiari, i ragazzi corrono a rotta di collo giù per i prati tagliando i tornanti, i cavalli hanno un passo allegro ed una energia che non avremmo davvero mai sospettata. Il sole fa scintillare il mantello color carbone lucido dei Mérens, hanno tutti quelle rotelle disegnate nel pelo che una volta chiamavano marenghi e dicono la prospera salute del cavallo; viene da pensare con tristezza a quelli che passano la loro vita chiusi in un box per 23 ore al giorno, lucidi soltanto di spray al silicone e nevrotici per la vita da reclusi che sono costretti a scontare per colpe non loro.
A sera i cavalli arrivano in paese, i ragazzini più giovani del gruppo sono lì di fianco ai puledri, mischiati al resto del branco come se fossero tutti una cosa sola; si legano i cavalli alle corde tese tra un albero e l’altro, gli stalloni che erano già qui nei box nitriscono per chiamare le cavalle, una fila di Haflinger biondi e spumeggianti come la birra fa da contrappunto al nero profondo ed elegante dei nostri “Prìncipi Neri” – che non c’è mica bisogno di essere tutti uguali per fare i cavalli da montagna. E i nostri hanno dimostrato di essere davvero nel loro ambiente su questi percorsi difficili: robusti e affidabili, calmi e pazienti, piedi più che sicuri e dotatissimi di quella particolare autonomia di giudizio che caratterizza i cavalli cresciuti al pascolo. “E poi – ci dice Marco Morra, Presidente dell’Associazione Allevatori del Cavallo di Mérens e avvocato di Genova che appena può mette la sella al suo morello montanaro e se ne va in giro per sentieri – questi cavalli hanno sempre attorno persone belle”. Ce ne accorgiamo guardando la gente che c’è qui in fiera, indaffarata coi cavalli o di passaggio per salutare gli amici, tutti sempre di corsa o alle prese con qualcosa da fare. Gente senza fronzoli ma con molta sostanza, capaci di difendere le proprie tradizioni e la propria individualità con rocciosa determinazione perché vogliono essere solo loro stessi, e non altri - “I cavalli sono domati, ma gli allevatori no!” dice Fortunato, due fanali azzurri da Giamburrasca spalancati sotto un cespuglio di capelli bianchi ingovernabili quanto lui. Qui l’amore per la propria indipendenza ha radici profonde, ci spiega Francesco Dematteis : “Sotto i marchesi di Saluzzo fino all’arrivo dei Savoia, nel 1601, i valligiani godevano per antichi accordi di una ampia autonomia anche religiosa. Molto più vicini alle città d’oltralpe che a quelle italiane erano in gran parte protestanti, ma c’era una pacifica convivenza tra confessioni diverse sino alle lotte della Controriforma che insanguinarono anche queste valli: coi cavalli siamo passati da Maseliero, dove i protestanti della Valle d’Unerzio tesero un’imboscata ai soldati dei Savoia che stavano arrivando per sterminarli. Fu un vero e proprio macello –masèl nella nostra lingua – e il ricordo di tutto quel sangue è rimasto anche nel nome della borgata”.
Dematteis è stato il primo a portare un Mèrens in Italia nel 1977, caricandolo su un Ford Transit e facendogli passare la frontiera in modo abbastanza avventuroso . Mi racconta la storia di questa valle, di come abbia lasciato Torino tanti anni fa per venire ad abitare proprio qui, di quando vanno nell’Ariége e possono parlare il loro dialetto e capirsi perfettamente con i montanari di là, occitani come loro divisi da tanti chilometri ma uniti dalle stesse radici e dalla stessa vita – e ora, anche dagli stessi cavalli. Gli chiedo come mai abbia organizzato questa transumanza: “Per ripercorrere tracciati che in antico legavano comunità affini e che adesso, a volte, hanno perso l’abitudine di comunicare. Una volta i limiti erano su altre basi, per parlare con qualcuno si facevano volentieri un po’ di ore a piedi, anche se era faticoso”. Guardo ancora i Mèrens che si mangiano tranquilli il loro fieno o si fanno portare nel ring da un paio di ragazzini alti un soldo di cacio, e intanto penso che Marco aveva proprio ragione: questi cavalli sanno scegliere molto bene la gente da tenersi attorno.
Maria Cristina Magri, da Cavallo Magazine nr.252 del 2007
Maria Cristina Magri, da Cavallo Magazine nr.252 del 2007
I cavalli dell’Ariége, detti di Mérens
L’Ariége è un dipartimento dei Pirenei francesi, vicino al confine con la regione spagnola dell’Andorra e dal piccolissimo paese di Mèrens prende nome il cavallo che è da secoli allevato in quelle zone. Il Mèrens è un cavallo di taglia media (non supera di solito il metro e cinquantacinque al garrese), notevole per resistenza e salute, l’ottimo carattere e la spiccata attitudine al lavoro su terreni difficili. Il mantello tipico è il morello zaino, sono tollerate piccole macchie bianche sulla fronte e balzane molto contenute. Preferisce vivere in alta quota, dove sfrutta al meglio i terreni marginali: è un ottimo cavallo da lavoro, si presta per il traino di slitte e tronchi e per il basto. E’ un perfetto cavallo da turismo equestre e al cavaliere riserva non solo tanta resistenza ma anche bei movimenti ampi. In più ha un talento spiccato per gli attacchi, specialità dove dimostra una predisposizione ed una capacità notevoli.
La transumanza:
http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&ie=UTF8&msa=0&msid=100985098135798129836.00043af70f4a35c7aa422&ll=44.461231,7.319641&spn=0.835089,1.60675&z=9&om=1
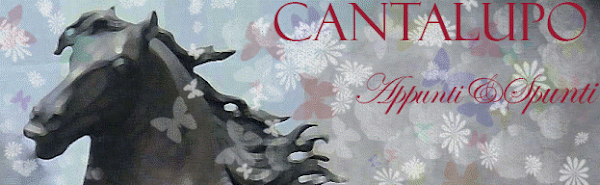






Nessun commento:
Posta un commento