Quando Mario Palumbo, allora Direttore di Cavallo Magazine, mi aveva mandata a fare il servizio su Fleur de Lys non aveva pensato ad una cosa: che io adoro le vecchie cose polverose e demodé. E al Centro Militare Veterinario di Grosseto c'è un magnifico museo, anzi meglio: custodiscono una splendida collezione di oggetti e attrezzature legati al mondo del cavallo e dell'equitazione e io non ho avuto pace finche il Dir non mi ha lasciato fare quello che m'era venuto in mente visitandola, cioè dedicare su Cavallo Magazine una puntata al mese ad uno degli oggetti di quel museo, per tirar fuori quello che c'era da raccontare sul suo uso e sul mondo che intanto ci girava attorno e già che c'eravamo fare un collegamento coi nostri tempi.
Così è nato il rubricone del Ce.Mi.Vet, questa era la prima puntata.
Le fotografie, splendide, erano di Carlo Valentini.
Il Ruolo Equini
Testo di Maria Cristina Magri, foto di Carlo Valentini
Nome, grado e numero di matricola: sono i dati identificativi di ogni militare che si rispetti e anche cavalli e muli arruolati nell’Esercito ne hanno sempre avuto diritto. Una delle prime preoccupazioni del Regio Esercito Italiano, prima ancora di darsi un nome che sarà ufficializzato solo nel 1884, fu quella di possedere un adeguato patrimonio equino: l’ancora giovane Regno d’Italia aveva bisogno di assicurare ai vari reggimenti i quadrupedi di pronto servizio, sia acquistandoli dal commercio (la cosiddetta “rimonta”), che allevandoli in proprio.
L’importanza strategica del patrimonio equino era fondamentale, per cui tenendo conto della popolazione locale e dell’indirizzo allevatoriale prevalente, venivano assegnati ad ogni Deposito Erariale stalloni approvati di diverse razze. Previo pagamento di un ragionevolissimo tasso di monta erano a disposizione di ogni allevatore, grande o piccolo che fosse, favorendo la crescita della qualità media nei nuovi nati. Di questo miglioramento traevano vantaggio sia gli allevatori che l’Esercito, che aveva così a disposizione soggetti migliori per i propri Centri di Rifornimento Quadrupedi. Ma come si teneva nota di ogni cavallo e mulo che ne entrava a far parte? Con l’accurata gestione in ogni reggimento di un registro anagrafico, il “Ruolo Equini”: una semplice scheda per ogni animale ne riportava nome, provenienza, età, razza, numero di matricola e dati caratteristici a cui venivano aggiunte nel tempo note sul suo stato di salute ed eventuali cambi di destinazione per poi arrivare alle cause della riforma (quando non era più “abile” al servizio) o della morte, nel qual caso l’anteriore sinistro dell’equino veniva asportato dalla carcassa e presentato come prova del suo decesso: erano un bene dello stato, e si voleva la matematica sicurezza di evitare distrazioni illecite.
Tutta la vita di un cavallo riassunta in bella calligrafia, migliaia e migliaia di animali raccontati con inchiostro e pennino e alla fine della sua esistenza un rigo di matita per traverso chiudeva una storia forse piccola, ma comunque unica e ben distinta dalle altre. Il numero di matricola di ogni quadrupede viene ancora oggi periodicamente impresso a fuoco su uno zoccolo (anteriore destro per i cavalli ancora in forza al Centro di allevamento come quello di Grosseto, sull’anteriore sinistro per tutti quelli già assegnati ai vari reggimenti), in modo che nonostante la crescita dell’unghia sia sempre ben leggibile. Erano poi in uso vari marchi da apporre sulla coscia sinistra: sia di razza (come quello della Razza Governativa di Persano, che porta l’arma sabauda timbrata dalla corona reale) sia relativi ad altre informazioni, come la croce scorciata che identifica ancora oggi i cavalli in forza al Centro Veterinario Militare, o la “R” che veniva una volta impressa ai soggetti riformati prima di alienarli. Possono sembrare metodi antiquati se li mettiamo a confronto con i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione oggi per la gestione dei dati, eppure funzionavano: il microchip si legge solo con lo strumento apposito (e a volte nemmeno con quello) mentre un numero sullo zoccolo è sempre visibile, anche ad occhio nudo.
Ancora oggi basta aprire un qualunque libro di ippologia stampato dal 1890 agli inizi della seconda guerra mondiale, o una rivista di zootecnia dello stesso periodo per sapere con precisione quanti cavalli esistevano in quel momento: ad esempio, alle riviste generali disposte dal Ministero della Guerra risultavano 702.390 soggetti nel 1894 e 741.379 nel 1900, ed è possibile rintracciare il dettaglio di ogni singolo stallone in attività sul territorio del Regno con tanto di nome, razza e dati del fiero proprietario compresi. E oggi? Nell’era dei micro-chip e della gestione telematica dei dati non sappiamo né quanti, né quali cavalli esistono in Italia, perché tutte le informazioni in possesso ad AIA (Associazione Italiana Allevatori che gestiscono i dati relativi agli animali iscritti ai vari Registri e Libri Genealogici riconosciuti), Asl veterinarie (le Aziende Sanitarie Locali, che si occupano degli allevamenti di qualsiasi tipo) e varie Federazioni Sportive (Fise per tutti gli sport olimpici, UNIRE per cavalli da trotto e galoppo etc. etc.) hanno raccolto i dati di loro pertinenza per la nuova Anagrafe Equina, ma nessuno ha ancora richiesto od utilizzato questa montagna di informazioni. Chi doveva farlo? L’Unire, a suo tempo incaricata (tra molte polemiche) della raccolta e gestione dei dati. Speriamo che questo problema venga presto risolto, o non potremo reggere il confronto col Ruolo Equino di ottocentesca memoria.
Cosa serviva per fare i cavalli:
Ministero della Guerra e Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio lavoravano fianco a fianco per ottenere lo stesso scopo: più cavalli allevati sul territorio nazionale e di sempre maggior qualità. Per ottenerlo si istituirono:
I Centri di Rifornimento Quadrupedi dell’Esercito, dislocati nelle regioni più adatte all’allevamento semibrado: Mirandola in provincia di Modena, Grosseto, Fara Sabina (al centro del Lazio), Persano in Campania e Bonorva in Sardegna. A questi si aggiungerà per una ventina d’anni anche quello del Carso che si trovava in zona austriaca sino al 1919 e passò nel 1946 alla Jugoslavia.
I Depositi Stalloni Erariali di Crema, Ferrara, Pisa, Santa Maria di Capua, Catania, Ozieri e Foggia. Ogni Deposito era fornito degli stalloni che più erano richiesti dal tipo equino allevato tradizionalmente nella sua zona: a Crema prevalevano i riproduttori da tiro pesante, sia lento che rapido, a Ozieri c’erano solamente per i cavalli da sella mentre negli altri si avevano soggetti sia da sella che da tiro rapido, importantissimo per l’artiglieria. I Depositi Erariali dipendevano dal Ministero dell’Agricoltura ma Direttori e personale di scuderia erano tratti dall’Esercito
le Commissioni Ippiche Provinciali, formate da “gente di cavalli” scelta tra ufficiali delle Armi a cavallo, veterinari e allevatori. Questi dovevano giudicare gli stalloni da adibire alla monta: dal 1889 infatti non potevano esercitare i soggetti che non fossero approvati dall’allora Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
.
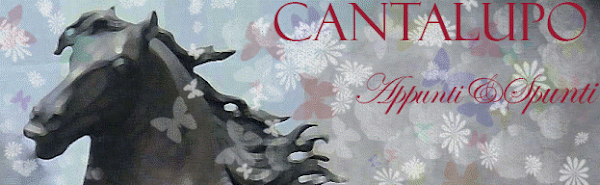







1 commento:
"Con l’accurata gestione in ogni reggimento di un registro anagrafico, il “Ruolo Equini”: una semplice scheda per ogni animale ne riportava nome, provenienza, età, razza, numero di matricola e dati caratteristici a cui venivano aggiunte nel tempo note sul suo stato di salute ed eventuali cambi di destinazione per poi arrivare alle cause della riforma".
Ecco cosa mi piace del tuo stile: descrivere le situazioni con l'esaustività che meritano e, come nel periodo da me riportato come virgolettato, curare con amore piccoli dettagli per trasmettere emozioni visive e non....(la scheda,la sua formazione, i suoi contenuti).
Secondo il mio personale parere abbiamo il dovere di educare le nuove generazioni ad apprezzare il bello delle cose passate che ci circondano.
Posta un commento